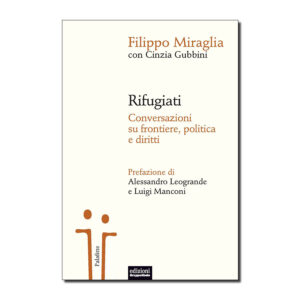Il 20 giugno 2023 si celebra la Giornata internazionale del rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di rafforzare gli sforzi per prevenire e risolvere i conflitti e contribuire alla pace e alla sicurezza delle persone rifugiate.
La Giornata internazionale del rifugiato è stata osservata per la prima volta a livello mondiale il 20 giugno 2001, per commemorare il 50esimo anniversario della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati. Inizialmente conosciuta come la Giornata dei rifugiati in Africa, è stata ufficialmente designata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite come una giornata internazionale con la risoluzione 55/76 del 12 febbraio 2001.
Nel 2016 Edizioni Gruppo Abele pubblicava Rifugiati. Conversazioni su frontiere, politica e diritti: un libro-intervista fra Filippo Miraglia – responsabile del settore immigrazione di ARCI – e Cinzia Gubbini, giornalista esperta del settore migrazioni. Un dialogo forte e interessante sul tema dei diritti delle persone – di tutte le persone – e sulla inesistente “emergenza migranti” di cui in Italia si parla da sempre.
Quello che segue è un estratto dal capitolo V, che tratta di discorsi d’odio e forze politiche che cavalcano il tema. L’intervista è stata registrata fra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, e al netto del cambiamento di alcuni protagonisti (ieri Salvini e la Lega, oggi Meloni e Fratelli d’Italia), l’analisi di Miraglia potrebbe essere stata scritta ieri.
A dimostrazione che l’Italia stenta a lasciarsi indietro un certo substrato politico e sociale, vittima di una “mutazione antropologica”, come la chiama Miraglia: il discorso pubblico e politico è ormai cementato su parole d’ordine tossiche come “invasione” e “prima gli italiani”, o il binomio logico “migrante = delinquente”.
Le domande di Cinzia Gubbini sono in corsivo e in colore rosso, le risposte di Filippo Miraglia in tondo
Discorsi d’odio, un veleno sottile
Alla crisi e all’irrilevanza della sinistra sul tema dell’immigrazione si contrappone, in Italia e in Europa, un’apparente egemonia della destra. Non c’è solo una crescita politica. C’è un’egemonia culturale, nel discorso pubblico. Con dei cambiamenti profondi, che tu hai definito addirittura antropologici. E rispunta un razzismo che non teme di manifestarsi in modo esplicito e palese.
Io vedo, oggi, più razzismo di ieri. E la sua spregiudicata utilizzazione come strumento di raccolta del consenso.
Dagli anni Novanta a oggi abbiamo assistito a una specializzazione del razzismo. All’inizio si sono sviluppate dinamiche che hanno visto, da un lato, la nascita di partiti xenofobi come la Lega e, dall’altro, l’inseguimento della retorica della sicurezza da parte delle sinistre di governo (dettate da spirito di emulazione o dalla paura di perdere consenso, soprattutto sui territori). Le due cose insieme hanno innescato un vero e proprio razzismo istituzionale, che ha avuto un effetto sulla cultura diffusa, ha agito nella testa della gente con conseguenze importanti. Il Paese ha conosciuto così un razzismo diffuso, che sta anzitutto nelle nostre teste senza che emergano anticorpi per combatterlo. Il razzismo ha avuto alti e bassi, spesso seguendo i ritmi delle campagne elettorali. Poi, a elezioni avvenute, le campagne a sfondo razzista si sono fatte ancora più rumorose in funzione di attacco al governo (in particolare quando ha governato il centro sinistra).
In seguito c’è stata un’evoluzione. Da un razzismo, diciamo così, “universalista”, quello secondo cui «i neri, gli immigrati sono diversi, inferiori, incompatibili con noi», siamo passati a una situazione maggiormente articolata. È più difficile, nel dibattito pubblico, scontrarsi con qualcuno che teorizza l’“inferiorità” dello straniero. È passata anche l’epoca delle politiche incentrate soltanto sulla sicurezza, sul fatto che gli immigrati sono pericolosi, sulle ordinanze per il decoro delle città, sugli sgomberi e sui sindaci sceriffi. Oggi siamo oltre: siamo in una fase in cui intorno ad alcune retoriche come la diversità culturale e religiosa o la presunta invasione, si è sedimentato un progetto politico. C’è, in altri termini, un investimento molto più ampio e strutturato, potremmo dire programmato, da parte di chi usa il razzismo come volano per una carriera politica. Pensiamo a quello che è successo alla Lega, che era praticamente scomparsa dal panorama politico. È arrivato Matteo Salvini e ha iniziato a utilizzare parole di odio, a dire – anzi a gridare – ossessivamente che «la colpa è degli stranieri: sono loro quelli che distruggono il Paese», facendo anche ricorso a parole politicamente scorrette. Questa strategia ha portato i talk show, ma anche la carta stampata, a dargli spazio, per ragione di audience. Ed è diventato il classico gatto che si morde la coda: più gli danno spazio, più diventa popolare; più diventa popolare più usa parole pesanti, perché questo lo rende interessante e fa crescere il numero delle interviste e delle apparizioni televisive. Così le parole d’odio prevalgono, diventano strumento di successo.
Ma questa dinamica comporta anche, appunto, una mutazione antropologica. Certi discorsi non appartengono più al panorama delle “chiacchiere da bar”, sono ormai penetrati nella testa della gente: dal dirigente, all’operaio, all’insegnante. Si è diffusa l’idea che l’articolo 3 della Costituzione, l’uguaglianza, non ce la possiamo permettere e che l’universalismo previsto nella Costituzione deve essere selettivo. Così sembra venir meno la possibilità di un progetto di convivenza democratica, di una società pluralista.
Le parole d’odio (hate speech per gli specialisti) sono diventate una moneta molto quotata, da spendere nel mercato del consenso. Una moneta a disposizione di politici che la usano per comprarsi spazi nel dibattito pubblico e consenso presso l’opinione pubblica. È il caso della Lega in Italia, della famiglia Le Pen in Francia, dei tedeschi di Alternative für Deutschland, di Farage in Inghilterra e di una serie di soggetti che hanno un peso rilevante nel dibattito politico per il continuo accesso alla stampa, per il condizionamento esercitato sugli altri soggetti del panorama politico, per l’influenza nell’orientare l’opinione pubblica. Si tratta di un processo sottovalutato e inedito, almeno con questa centralità e queste dimensioni. Siamo cioè di fronte a un razzismo post moderno, che ha prodotto e produce effetti duraturi.
So che la questione dei “discorsi d’odio” (in originale hate speech) ti sta particolarmente a cuore. Puoi spiegarmela più diffusamente?
È una questione assolutamente centrale. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento dello spazio riservato nel dibattito pubblico a coloro che utilizzano parole d’odio verso singole persone o verso gruppi di persone. Avviene dappertutto, non solo in Italia. Ho citato Salvini e la rinascita della Lega. Ebbene, questa rinascita non è avvenuta in conseguenza di una più marcata presenza politica sul territorio, ma a seguito di una accorta strategia di utilizzo dei media. Salvini ha capito come usare i mezzi di comunicazione: sdoganando il discorso dell’odio e predicando l’intolleranza ha creato un “personaggio”. In virtù dell’odio che predica viene invitato nei salotti televisivi acquisendo popolarità. Ma intanto le idee da lui esposte entrano in circolo e non sembrano più così incredibili. Ora chiunque si può permettere di dire cose che ieri erano magari pensate ma che il “politicamente corretto” impediva di dichiarare apertamente. Di conseguenza le persone accettano come vere cose non dimostrate, luoghi comuni che entrano a far parte della nostra cultura media. Peggio ancora, si danno per acquisite verità non dimostrate e non dimostrabili. Non più le verità inventate che potevano essere utilizzate nei discorsi da bar, ma “false evidenze” utilizzate nei salotti televisivi, nei talk show e nei dibattiti politici, sui mass media mainstream.
Vedo che tu metti sotto accusa stampa e televisione, ma i leader della destra xenofoba, in Italia e in Europa, hanno un consenso forte. Forse parlano semplicemente come la gente chiede?
C’è anche questo. Ma, soprattutto, a fronte di chi, avendo sperimentato l’efficacia delle parole d’odio, fa ricorso ad esse per conseguire una egemonia culturale, manca una risposta della sinistra e delle forze democratiche adeguata, all’altezza della situazione. Non c’è, nella competizione per l’egemonia culturale, un soggetto che abbia investito su un linguaggio diverso, alternativo e di pari importanza rispetto a quello della destra.
C’è chi dice che i discorsi d’odio sono fuori della dialettica della libertà di opinione e che i loro autori devono essere portati in tribunale. Tu cosa pensi?
Penso che gli strumenti giuridici ci siano già e che non ne servano altri. Forse sono poco utilizzati, ma quel che conta di più è il contesto culturale che finora è stato sottovalutato dalla politica, dalla sinistra, dalle forze democratiche e anche dalle istituzioni. I discorsi d’odio sono attribuiti spesso alla “particolarità” dell’estrema destra, dei movimenti xenofobi, come se fossero una loro caratteristica esclusiva. Pertanto l’hate speech non viene percepito come uno strumento dell’avversario da combattere in quanto tale. Io credo che l’azione giudiziaria debba essere utilizzata dentro una strategia esplicita di attacco alle parole d’odio. Se Salvini viene invitato in tutte le trasmissione televisive, bisogna dire in modo chiaro che i direttori di testata, i conduttori, i giornalisti sono colpevoli di dare uno spazio assolutamente sproporzionato a chi incita all’odio e al razzismo. Questa prospettiva deve essere molto più aggressiva: se qualcuno invita Salvini e Salvini pronuncia parole d’odio, io devo poter attaccare chi ha fatto questa scelta chiamandolo in causa come complice. Punto e basta.