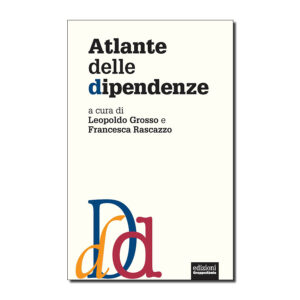L’uso di droghe e sostanze stupefacenti è, nell’immaginario collettivo, parte integrante del mondo delle rockstar. Vite di eccessi, mitizzate – e non sempre veritiere – che a volte terminano in tragedia, morti sotto la lente dei media che catapultano i cantanti direttamente nella leggenda (chi non ha mai sentito parlare del Club 27?).
Atlante delle dipendenze, a cura di Francesca Rascazzo e Leopoldo Grosso, raccoglie in maniera analitica e rigorosa i fenomeni di dipendenza da un punto di vista sociale e culturale, scientifico e legislativo. Una delle 98 voci che compongono questo corposo volume è Musica e droga, scritta da Fabio Cantelli Anibaldi: un capitolo intero dedicato ai legami fra il mondo della musica e l’uso (e l’abuso) di droghe, con un inedito punto di vista in prima persona. Proponiamo ai nostri lettori l’intero capitolo qui di seguito.
Musica e droga, di Fabio Cantelli Anibaldi
Dovremo dunque limitarci a sorvegliare i poeti costringendoli a trasfondere nelle loro opere il modello delle buone consuetudini, oppure dovremo curare anche altri artisti, per impedire che riproducano questo malcostume dissoluto, volgare e vergognoso?
(Platone, Repubblica, libro III)
Intorno ai diciottanni mi capitò di leggere Su e giù con i Rolling Stones, libro in cui Tony Sanchez, factotum di Keith Richards – la parola indicava una serie di mansioni, dall’autista al guardaspalle al pusher – racconta le avventure passate a fianco del più sfrenato degli Stones, simbolo stesso del rock come dissipazione e gioco autodistruttivo. Come ogni fan che si rispetti, rimasi anch’io affascinato da pagine zeppe di aneddoti memorabili, ma presto fu chiaro, leggendo altre cose del genere, che ricalcavano un canone o per meglio dire un cliché, e che quanto più il legame fra musica e droga rientrava in una mitologia dell’eccesso, tanto più le sue origini restavano oscure.
Ragione di questo scritto è il cercare – per quanto possibile nello spazio di poche pagine – le origini di quel legame, che forse sono molto più remote di quanto crediamo.
Platone il “rottamatore”
Il primo a parlare non di musica e droga ma della musica come di una droga è stato infatti Platone. Nei celebri passi del terzo libro della Repubblica, la poesia e la musica vengono passate al vaglio di una severa critica pedagogica in quanto arti nocive alla buona formazione del cittadino. Alla nostra sensibilità di moderni la cosa pare inaccettabile, tanto che molti hanno giudicato Platone un reazionario e La Repubblica un manifesto dei totalitarismi. Il realtà Platone è il primo grande “rottamatore” della storia, per usare una brutta parola molto in voga. Discepolo di Socrate, si rende conto che la nascita di una comunità razionale, cioè di una società quale ancora oggi la intendiamo – la società della politica, delle istituzioni, delle leggi scritte – richiede il sacrificio della comunità del mito. Ma sacrificare il mito, dirà Nietzsche, altro grande rottamatore, significa sacrificare la vita stessa. Nella Nascita della tragedia, opera in cui distrugge l’idea di una Grecia tutta forme, misure e armonia, Nietzsche mostra il caos che brulica nelle nostre vite ma soprattutto come una vita che rifugge il caos rifugge anche la possibilità d’essere felice. Questa felicità ha per Nietzsche un nome preciso: Dioniso, il dio della danza, della musica e della perdita di sé. «Solo partendo dallo spirito della musica – scrive – possiamo comprendere la gioia per l’annientamento dell’individuo».
Non è solo Nietzsche, però, a collocare l’ispirazione in zone infere. Il baccano di Dioniso già scuote l’Europa alla fine del Settecento, musica alle orecchie di uomini bislacchi ma molto geniali. I Romantici sono gli ultimi a credere al ritorno degli dei, credere che le società possano tornare a essere comunità dove, a precise ricorrenze – feste, processioni, carnevali – si spalanchi una finestra sull’abisso. Ma nell’Europa delle «magnifiche sorti e progressive» quella finestra è ormai una vena atrofizzata. E non essendoci di dei neanche l’ombra, l’ebbrezza diventa esperienza privata, sottratta al tempo del lavoro e dunque resa al lavoro funzionale, “ottimizzata”, diremmo oggi.
«È possibile cogliere il sacro?» si chiede Friedrich Schlegel. E risponde: «No, esso non può mai essere colto, perché la mera imposizione della forma lo deforma». Perso nei suoi deliri, il poeta finisce per sembrare, dice con qualche compiacimento Diderot, «un uccello notturno e selvaggio, creatura non addomesticabile con il suo tetro, malinconico piumaggio». E, straniero su questa terra, decide talvolta di abbandonarla. “Filosofie del colpo di pistola”, le chiamerà Hegel. E chi sono Kleist, Hölderlin – e più avanti Lautréamont e Rimbaud – se non rockstar ante litteram?
Le droghe, Dioniso e i borghesi
Alla fine del secolo successivo, altro movimento tellurico. Solo che Dioniso, stavolta, sceglie di camuffarsi nelle fantasie notturne di rispettabili borghesi. La materia, scottante, finisce nelle mani di due acuti indagatori del profondo. Il primo dubita della scienza, vede archetipi dovunque e finirà per dire: «Gli dei sono diventati malattie» (C. G. Jung, Jung parla, Adelphi, Milano, 1995). Il secondo è un positivista che non si sognerebbe mai di vedere nelle malattie l’orma del sacro, ma solo il risultato di una vitalità repressa: «Se la civiltà impone sacrifici così grandi non solo alla sessualità ma anche all’aggressività dell’uomo, allora intendiamo meglio perché egli stenti a trovare la sua felicità in essa. Di fatto l’uomo primordiale stava meglio, poiché ignorava qualsiasi restrizione pulsionale (…). L’uomo civile ha barattato una parte della sua possibile felicità con un po’ di sicurezza».
Le pagine del Disagio della civiltà sono scritte nel 1929, e stupisce che un genio della grandezza di Freud non veda che il baratto vige solo in apparenza: nel profondo l’uomo continua a volere la felicità, anche a prezzo della vita. Le trincee di Verdun o della Somme sono luoghi di morte e sofferenza. Ma sono anche luoghi di ebbrezza, non bisogna dimenticarlo. Chi l’ha provato non lo dimentica affatto: finita la guerra, molti reduci non trovano pace. Anime perse, arrancano ai margini di una società cui non riescono ad adattarsi, afflitti da una nostalgia senza nome che cercano di mitigare con l’alcol e la droga, pallidi surrogati di una vita ad altezza di morte.
Sfugge a Freud ciò che Nietzsche invece coglie con chiaroveggenza, ossia che la morale – la “restrizione pulsionale” – è ormai un idolo di carta, senza potere vincolante, riverito solo per stanca consuetudine. E che cadrà non già per l’arrembaggio delle pulsioni, ma perché nella vita tecnicamente organizzata a decidere cosa è bene è il principio d’efficacia. Se nelle trincee la vista del nemico poteva richiamare alla compassione o almeno alla comune sventura («Ero venuto per colpire un fascista. Ma un uomo che regge i pantaloni che stanno per cascargli non è un fascista, è un nostro simile» scrive Orwell nei ricordi della guerra civile spagnola), nelle incursioni aeree su Hiroshima o Dresda il nemico è più soltanto un’astrazione, un dato statistico, la sua distruzione una necessità dovuta a fredde esigenze produttive. In quella vita ridotta a piccola ragioneria Dioniso non sembra avere spazio, ma il dio dell’ebbrezza non segue il corso della storia: lo determina. Ed eccolo riapparire là dove meno te lo aspetti, nel cuore stesso della potenza tecnologica.
Droga e rock ‘n’ roll
I Paesi occidentali, e gli Stati Uniti in particolare, conoscono alla fine della guerra un picco demografico senza precedenti. Non solo: molti dei genitori che hanno avuto un figlio morto in guerra, decidono di metterne subito al mondo un altro. I baby boomers crescono in un’epoca che ha fretta di dimenticare le macerie del passato e in famiglie dove la distanza tra genitori e figli è grande dal punto di vista anagrafico, enorme da quello culturale.
Il contagio si diffonde come altre volte nella modernità, solo che adesso si avvale dei mezzi di comunicazione di massa: tv e giornali, film e libri. Ma soprattutto del veicolo da sempre prediletto dal dio: la musica.
Figlio del blues, canto inventato dai neri nei campi di cotone, nasce negli anni Cinquanta il rock’n’roll, impaziente e sfrontato. Se il primo vuole dimenticare le catene, il secondo vuole spezzarle. Per milioni di giovani è un richiamo della foresta e un guanto di sfida gettato in faccia ai padri, che non capiscono, come negli anni Venti i borghesi parigini non capivano le dissacrazioni dadaiste, l’arte capovolta di Tristan Tzara e di Marcel Duchamp. Solo che la partita non si gioca più nell’ambito delle élite, salotti o raffinate riviste letterarie. La distanza che emerge dall’avvincente epistolario tra il giovane Antonin Artaud e un borghese intelligente come Jacques Rivière, direttore della Nouvelle Revue Française – nel quale uno chiede: «Perché mentire, perché cercare di porre sul piano letterario una cosa che è il grido stesso della vita?» e l’altro risponde: «Lo spirito è fragile in quanto ha bisogno d’ostacoli, d’ostacoli avventizi. Solo, si perde, si distrugge», si gioca adesso su larga scala, su un palcoscenico vasto quanto il mondo e con la pretesa di cambiarlo. L’obbiettivo, apertamente politico, trova un ulteriore appiglio nel Vietnam, dove i figli sono costretti a combattere una guerra dichiarata dai padri. In una scena di Apocalypse now si vede l’equipaggio del capitano Willard risalire il Mekong in un momento d’apparente tranquillità. Il ragazzo di colore accende la radio e, salutati i soldati al fronte, lo speaker trasmette la raccomandazione del sindaco di Saigon: non esporre sui balconi la biancheria perché la città deve apparire linda e decorosa (un capo di governo, ignaro del capolavoro di Coppola, manifestò la stessa preoccupazione in occasione del G8 di Genova). Parte poi Satisfaction degli Stones e, mentre l’euforia cattura l’equipaggio, la cinepresa inquadra Lance, il campione di surf, impegnato a fare sci d’acqua agganciato alla motovedetta…
La relazione fra musica e droga, così come la immaginiamo, trova origine in quegli anni turbolenti. Prima la droga ballava da sola, per così dire, tutt’al più accompagnata dal jazz di musicisti spiantati come il Frank Sinatra dell’Uomo dal braccio d’oro, batterista tossicomane che conduce una vita grama fra bar fumosi, spacciatori e crisi d’astinenza interpretate con foga caricaturale. Un mondo già descritto con ben altra forza in Junkie, il grande romanzo che per primo rivela la tossicomania senza indebiti romanticismi, con uno sguardo insieme gelido e visionario, riportandola a quella che l’anatomista Burroughs chiama “algebra del bisogno”. Pagine dove la musica non c’è o, se c’è, è puro elemento di corredo.
Rivoluzione psichedelica
Solo negli anni Sessanta, con la rivoluzione pischedelica, droga e musica avanzano di concerto, sicché non è facile dire dove inizi l’una e finisca l’altra. Mentori del connubio, intellettuali di vaglia come Aldous Huxley, grandi scrittori come Henry Michaux o Ernst Jünger (che però, quando prova l’LSD col suo inventore, il chimico Albert Hofmann, accompagna l’esperimento con il concerto per flauto e arpa di Mozart) ma pure incantatori come Tymothy Leary, il professore di Harvard che sogna una palingenesi sociale a base di acido lisergico, tanto da meritarsi da Nixon l’appellativo di «uomo più pericoloso d’America».
Su queste cose – il flower power, i pellegrinaggi in India, la poetica “on the road”, i sit-in per la pace, la Londra psichedelica, Lennon e Yoko Ono e chi più ne ha più ne metta – sono state scritte migliaia di pagine. Nelle ricostruzioni di quegli anni c’è però un evento lasciato ingiustamente in ombra, oscurato dalla contiguità con Woodstock e dal fatto di cronaca cui viene associato. Il 6 dicembre del 1969 i Rolling Stones, assenti a Woodstock, decidono di ripagare il pubblico americano con un concerto gratuito a San Francisco. Tre giorni prima, però, l’amministrazione cittadina non concede l’autorizzazione e gli organizzatori sono costretti a trovare una soluzione in fretta e furia. Viene individuato l’autodromo di Altamont, a un centinaio di chilometri. Quel giorno però tutto gira storto: l’organizzazione rabberciata, l’enorme affluenza di pubblico, la quantità di droga assunta e non ultima, la scriteriata scelta di affidare il servizio d’ordine agli Hell’s Angels, banda di energumeni motorizzati che dagli anni Cinquanta seminano il panico dovunque vadano. Durante l’esecuzione di Under my thumb Meredith Hunter, un ragazzo di colore – pare armato, ma la cosa non verrà mai accertata – si avvicina al palco. Un Hell’s Angel lo agguanta e comincia a pestarlo, subito seguito dai sodali. Il ragazzo viene portato via agonizzante. Il concerto prosegue, ma ormai l’incanto è svanito. Nell’atmosfera raggelata sembra chiudersi un cerchio: a Verdun si aspettava la morte e si trovò anche l’ebbrezza. Ad Altamont, si cercava l’ebbrezza e si è trovata anche la morte.
C’è chi ha parlato di “fine dell’illusione”, ma è formula da sociologia spicciola. Più esattamente è l’esito di un “disagio della civiltà” riveduto e corretto nella versione dei critici del capitalismo, si tratti di marxisti come Marcuse o mistici-sapienziali come Bateson. Studiosi che celebrano la multidimensionalità dell’essere umano, annichilita dall’apparato occidentale, ma non spiegano come per tenere insieme quelle dimensioni occorra una buona dose d’autodisciplina. È quello che Rivière cercò di dire ad Artaud: un governo ci vuole. E se non accetti che siano gli altri a importelo, magari per un tuo presunto bene, provvedi a dartelo da solo. «Mi sembra che questa “erosione” mentale che affligge il suo spirito – scrive ancora Rivière – non abbia altra causa che la troppo grande libertà lasciatagli. È l’assoluto a guastarlo (…). Il solo rimedio alla pazzia è l’innocenza dei fatti».
Il pantheon del rock
Gli anni Settanta sono quelli in cui si cerca d’imporre coi fatti, non più innocenti, ciò che prima pareva scaturire dall’ordine stesso delle cose. E, quanto a musica e droga, quelli dei referti medici e dei necrologi. Comincia Brian Jones, il più fragile degli Stones, annegato in piscina per overdose nell’estate del ’69. Lo seguono a distanza di pochi mesi Jimi Hendrix e Janis Joplin. Il pantheon del rock comincia ad affollarsi come il cimitero di Père Lachaise a Parigi attorno alla tomba di Jim Morrison, meta di pellegrini che vi lasciano biglietti e amuleti, magari ignorando che, oltre al cantante dei Doors, là attorno sono sepolti artisti immensi come Wilde e Proust, Chopin e Albert Camus.
Come ogni chiesa che si rispetti, anche quella del rock ha le sue dottrine, le sue liturgie, i suoi santi. Ma anche una generosa disponibilità ad annettere scritture apocrife su prodezze e miracoli d’ogni genere, purché utili alla causa.
Ecco allora Keith Richards che si fa cambiare il sangue in misteriose cliniche svizzere – come altrimenti spiegarne la longevità? – o Eric Clapton che vende le sue chitarre per comprare eroina. Ecco che, ascoltata all’incontrario, Helter Skelter dei Beatles rivela messaggi satanici che eccitano la mente omicida di Charlie Manson, l’assassino di Sharon Tate, o Lou Reed che s’inietta eroina sul palco, eseguendo Heroin (è una bufala: una foto, reperibile su Internet, rivela che si limita a mimare il gesto, usando il cavo del microfono come un laccio emostatico e una penna come siringa). Ed ecco l’aura che già avvolge i martiri di nuove, benvenute eresie come il punk o la new-wave: Sid Vicious che accoltella la fidanzata Nancy Spungen al Chelsea Hotel, leggendario buen retiro di artisti e poeti beat, per poi uccidersi con l’eroina appena uscito di prigione. O Ian Curtis, che prima d’impiccarsi pare abbia scritto: «questa è la fine dello show, questo è lo show della fine». Joy Division, si chiama la sua band, ed è un beffardo controcanto al peace&love degli anni Sessanta, visto che “reparto della gioia” veniva chiamata nei lager la baracca adibita a bordello per soddisfare le voglie delle SS…
Droga e adolescenti
Su migliaia di adolescenti disorientati l’effetto è lo stesso della musica del pifferaio sui poveri topi. La droga non è più materia cui accostarsi con slancio da apprendisti stregoni. È zattera di naufrago o cornicione di sonnambulo, a seconda dei punti di vista. Non le si chiedono rivelazioni: solo un po’ di quiete, un po’ di calore, un po’ d’oblio.
Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, scritto da una ragazza che si firma con lo pseudonimo Christiane F., esce in Germania nel 1979, in Italia due anni dopo. Racconta una dipendenza scandita da una sorta di squallida routine impiegatizia: marchette, furti, bugie ai genitori, ricette false, tentativi falliti di disintossicazione, collassi in squallidi gabinetti del metro. La stampa si scandalizza, senza rendersi conto che lo stesso sta accadendo nelle grandi città italiane, a Milano, a Torino, a Roma. Come il libro, anche il film è mediocre, ma almeno ha il pregio di far vedere David Bowie, trasferitosi proprio a Berlino per sfuggire alla cocaina, di cui quei ragazzi amano, oltre alla musica, la bellezza all’apparenza incorruttibile, come quella del marziano che Bowie interpreta, o meglio incarna, nell’Uomo che cadde sulla terra.
Il resto è storia recente. Nei decenni dell’ideologia del mercato – la più forte di tutte perché incoraggia il desiderio – la droga perde la sua epica. Droga e tossicomane sono parole che appaiono ormai solo in rozze cronache giornalistiche. Gli esperti parlano di “sostanze” e di “gente che consuma”, in ossequio alla generale tendenza di coprire le scabrosità della vita con un manto di parole neutrali. Peccato sia la stessa strategia del mercato, che per vendere il desiderio ha bisogno di sterilizzarlo, presentarlo come un gattino domestico nelle cui vene ha smesso di scorrere il sangue di Dioniso.
Da Kurt Cobain ai rave
Anche il rapporto musica e droga ne risente profondamente. L’ultima figura rilevante del martirologio rock è Kurt Cobain, il leader dei Nirvana, sconfitto a 27 anni da una depressione che nemmeno l’eroina riusciva a lenire.
Geniale disadattato come l’America di tanto in tanto riesce a sfornare, Cobain è l’interprete di una musica come lui timida e scorbutica, gelosa della propria selvatica rudezza, incurante del favore quanto della riprovazione del pubblico. Erede in questo del punk, salvo che un po’ di rabbiosa vitalità il punk ce la metteva, mentre qui pare esserci solo malinconia e humor nero, e l’urlo che ne scaturisce è come quello di Munch, afono e assordante.
La vicenda di Kurt Cobain è forse l’ultima in cui le orbite di musica e droga convergono in maniera poeticamente nitida nella vita di un individuo. L’epica dell’eccesso diviene in seguito appannaggio di copywriter e esperti di marketing, capaci di trasformarci tutti in superuomini di massa, tesi a recitare lo stesso copione della stessa inimitabile vita. La dizione solenne di alcune pubblicità – si tratti di reclamizzare un’auto o una pomata per il mal di schiena – attesta il livello cui è giunta la parodia.
Il tema musica e droga imbocca a questo punto due strade che più divergenti è impossibile immaginare. Da un lato la cultura techno e il connesso fenomeno dei rave, dove la musica e la droga vivono pressoché in simbiosi, generando momenti di estasi collettiva. Nella techno non esiste epica dell’eccesso per il semplice fatto che qui il mito s’esaurisce nel rito, il quale a sua volta coincide col ritmo, risposta elementare del nostro essere al mondo e del nostro essere il mondo.
Un film come Berlin Calling, incentrato sulla figura del dj Ikarus, interpretato da Paul Kalkbrenner, musicista tra i più amati della scena, descrive bene l’universo di questi barbari sensibili che scrivono e trascrivono sequenze ritmiche al computer con meticolosità di monaci di clausura, e sobbalzano all’idea di doversi liberare da droghe – ecstasy o altri intrugli chimici – per loro altrettanto naturali quanto può esserlo, per l’indio peruviano, la pianta della coca.
Comunità liquida
È difficile prevedere lo sviluppo di queste forme di aggregazione e l’influenza che sapranno esercitare sulla società “politica”. Certo è che il fenomeno della techno non riguarda né la sola musica né il solo costume e nemmeno le due cose insieme. È fin troppo evidente, a uno sguardo appena libero dall’ansia di giudicare, che a essere evocata in questo caso è la nostra sete di trascendenza, sicché non è da escludere che le comunità dei rave anticipino a loro modo una comunità del futuro, “liquida” ma niente affatto virtuale, dove il principio della fratellanza viene subordinato a quello del piacere, diversamente da come è stato nelle utopie finora conosciute.
La seconda strada è il Sunset boulevard del mito, la sua definitiva iscrizione nel registro dell’informazione di massa. Processo già in atto, se è vero che il tema musica e droga è ormai declassato a gossip relativo al tal cantante o alla tal attrice, le cui peripezie – tra rehab, arresti, lacrime e intemperanze pubbliche – alimentano il narcisistico gioco di specchi di cui Michael Jackson è stato al tempo stesso simbolo e agnello sacrificale.
Come è pure vero che questo processo è un fatto della vita e dunque tale da riservarci impensabili sorprese. Accade talvolta, infatti, che nella grande rete a strascico restino impigliate creature atipiche, “inadatte”, provenienti da chissà quali profondità. Riportate in superficie, sanno deliziarci e scuoterci con l’intensità quasi dolorosa del loro canto, prima che il demone da cui sono possedute le richiami a sé. Amy Winehouse, morta nel luglio del 2011 a soli 27 anni – come Brian Jones, come Jimi Hendrix, come Janis Joplin, come Kurt Cobain – era una di queste.
PER APPROFONDIRE
Fabio Cantelli Anibaldi è stato addetto stampa della Comunità di San Patrignano. È stato co-direttore di Narcomafie e responsabile dell’ufficio stampa del Gruppo Abele Onlus. Ha pubblicato La quiete sotto la pelle (Frassinelli, 1996) e con Carlo Sini ha scritto La verità è un’avventura. Conversazioni sulla filosofia e sulla vita (Edizioni Gruppo Abele, 2013). È stato vicepresidente del Gruppo Abele Onlus dal 2020 al 2023.
Musica e droga è tratto da Atlante delle dipendenze, cap. X Informazione e rappresentazioni, pp. 650-656. Il testo originale contiene note a piè di pagina.