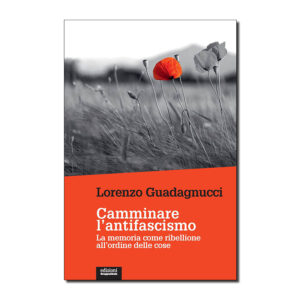Secondo una vulgata che andrebbe quanto meno circostanziata e soprattutto circoscritta, la Germania e i tedeschi avrebbero fatto i conti con il proprio passato nazista ben più e meglio di quanto noi italiani abbiamo fatto con il ventennio fascista e i suoi orrori. In verità, a Berlino come a Roma, la continuità dello Stato dopo la fine della guerra – nelle persone e anche nella cultura di riferimento – fu ben più stringente di quanto si è voluto ammettere e le dolorose vicende dei crimini di guerra, con il difficile percorso della giustizia, ne sono la logica derivazione.
La sentenza di Bologna sui risarcimenti alle vittime della strage di Monte Sole mette a nudo alcune verità, pur in mezzo a vari paradossi. Fa capire, per esempio, quanto poco la Germania abbia accettato la ricerca delle responsabilità avvenuta nei tribunali italiani. Il giudice civile, sulla scorta di una storica sentenza della nostra Corte costituzionale del 2014, ha messo un limite netto al principio di immunità degli Stati, mostrando quanto sia stata opaca e poco lungimirante la scelta di Berlino di opporsi alle richieste di risarcimento. Si dirà: la Germania si sarebbe esposta a una serie infinita di processi di tutta Europa e ha cercato di proteggersi. Certo, ma ci saremmo tutti risparmiati, Germania inclusa, una grave lesione ai princìpi di giustizia e responsabilità dell’ordinamento internazionale, cui le corti italiane stanno tentando di porre rimedio. Il paradosso è che sarà lo Stato italiano, con appositi stanziamenti, a pagare i (magri) risarcimenti per i crimini commessi dai militari tedeschi: le vie della diplomazia e dell’opportunismo sono davvero infinite.
La Germania – non dimentichiamolo – ha rifiutato negli anni scorsi anche le condanne penali inflitte a qualche decina di militari tedeschi per le numerose stragi avvenute in Italia fra 1943 e ’45. I processi degli anni Duemila – per Monte Sole e Sant’Anna di Stazzema, ma anche Vallucciole, Fivizzano, Fucecchio, Civitella Val di Chiana e vari altri – avviati dal procuratore militare Marco De Paolis sulla base dei fascicoli archiviati (illegalmente) nel cosiddetto “armadio della vergogna”, hanno segnato una pagina importante nella punizione dei crimini di guerra e contro l’umanità, ristabilendo la centralità della tutela della persona umana e della sua dignità, eppure le condanne non sono state mai recepite dalla giustizia tedesca, con vari espedienti giuridici.
La sentenza di Bologna è parte di un conflitto giuridico, politico e culturale attorno all’effettiva tutela dei diritti umani, spesso invocati, proclamati e magari esibiti come una bandiera, salvo essere negati o accantonati quando una certa idea di realpolitik prende il sopravvento. La seconda guerra mondiale fu una tale rovina, che si tentò di prevenire nuovi conflitti con le Costituzioni, i Trattati internazionali, la nascita dell’Onu, la Dichiarazione sui diritti umani, cioè un sistema di relazioni fra Stati basato su un’attitudine cooperativa e su nuovi strumenti di giustizia internazionale. Questa trama di relazioni, diritti e istituzioni è stata via via sgretolata e le guerre con i relativi crimini contro i civili sono tornate a essere il nostro presente, perciò tale trama va ricostituita e rafforzata con urgenza. La sentenza della giudice bolognese si muove nella direzione giusta.
Lorenzo Guadagnucci
Riportiamo qui un estratto dal capitolo 2 di Camminare l’antifascismo. La memoria come ribellione all’ordine delle cose, di Lorenzo Guadagnucci. Il gruppo delle Camminate antifasciste si ferma alle pendici del Monte Sole, nei pressi di Marzabotto, e lì riflette sulle emozioni nate durante la Camminata e sul tempo presente.
Eseguire gli ordini?
Ieri sera a tavola abbiamo parlato delle prime impressioni riportate passeggiando fra ruderi e sentieri. Ci siamo sistemati nell’ostello gestito dai «dossettiani», come vengono chiamati frati e suore della Piccola Famiglia dell’Annunziata. È una vecchia e grande casa di campagna, ristrutturata e arredata semplicemente, molto rustica ma confortevole, con camere spaziose e gli immancabili letti a castello. Davanti all’ingresso, la grande aia è lo spazio ideale per una cena di gruppo, in piena estate, sui lunghi tavoli di legno. Sull’altro lato della casa, la vista spazia verso la vallata, abbracciando un paesaggio dolce e pacificante. Appena oltre il cancello, il vecchio abitato di Cerpiano, oggi solo ruderi, quanto resta di una frazione che al tempo della guerra svolgeva un ruolo importante nella comunità, col grande edificio detto il Palazzo, sede dell’oratorio e della scuola. Vi morirono fra enormi sofferenze decine di persone, inclusi molti bambini. Siamo insomma nel cuore della tragedia.
Abbiamo preparato la cena in fretta, senza accendere fornelli. Tutto cibo crudo o freddo comprato alla partenza, un pasto di grande sobrietà, in sintonia con lo stato d’animo generale, orientato a cogliere l’essenziale. Siamo tutti coscienti d’essere ospiti di un luogo carico di dolore, d’essere esploratori dell’animo umano, nostro e altrui. E tutti vogliamo vivere il nostro tempo in questo luogo senza distrazioni, prestando attenzione anche alle sfumature.
Doriana, che ha portato alla Camminata Patrick, il ragazzo arrivato dal Ghana, ha riassunto in poche parole una sensazione che è stata comune nel pomeriggio trascorso a vagare fra i sentieri, a visitare i luoghi dell’eccidio, a leggere i cartelli informativi uno dopo l’altro. Doriana e un’insegnante, ha un approccio analitico alle cose, ma si lascia influenzare dalle emozioni, non sembra temerle, semmai accoglierle per quello che sono, il sale della vita quotidiana. «Non ero mai stata a Monte Sole ma ho sentito tanto parlare della strage di Marzabotto che mi e sempre sembrata una storia familiare. Però la passeggiata di oggi mi ha sorpreso e impressionato. Sono rimasta colpita dal vuoto. Sono stata spesso a Sant’Anna di Stazzema: li ci si sente piccoli e indifesi, si avverte un clima di cupezza. Qui è diverso: prevale il vuoto, il senso di solitudine. Davanti alla chiesetta di Casaglia avevo un groppo alla gola e mi e venuto da pensare: meno male che siamo qui tutti insieme e che possiamo condividere questo patema. Da sola, ne sarei stata travolta».
Per fortuna c’era un po’ di confusione a tavola, anche un pizzico di euforia, se vogliamo. È normale, alla vigilia di un’esperienza piccola ma attesa e preparata per tanto tempo, e con tre ragazzi esuberanti e più eccitati degli altri. È stata una serata di chiacchiere, di alzate di voce, a tratti anche di allegria, come si conviene a ogni piccola impresa di gruppo. Un’allegria forse in contrasto con l’aura di Monte Sole, ma coerente con lo spirito della Camminata: riconoscersi come eredi o come seguaci di quelli che scelsero nell’ultima guerra combattuta in Italia di stare dal lato giusto della storia. Così ci sentiamo. Vicini alle vittime di allora, e poi antifascisti, partigiani nello spirito.
Nicola ieri sera ha raccontato agli altri qualcosa della Piccola Famiglia dell’Annunziata e di Giuseppe Dossetti. Ne ha ricordato, soprattutto, il remoto passato politico alla Costituente e nella Democrazia cristiana e il clamoroso ritorno sulla scena pubblica, dopo quarant’anni di assenza, per contrastare i propositi di modifica della Costituzione annunciati dalla destra al potere nella «seconda Repubblica». Era il 1994 e Dossetti, il monaco dimenticato, tornò a farsi sentire per difendere la Carta che aveva contribuito a scrivere. Nel progetto di riforma vedeva propositi autoritari inaccettabili, un tradimento dello spirito che aveva animato i costituenti. Nacquero in quella fase, in suo appoggio e dietro sua esplicita indicazione, i Comitati Dossetti in difesa della Costituzione: diedero un contributo rilevante al dibattito che alla fine impedì ogni riforma e testimoniarono la vitalità del nesso che unisce la Resistenza e la nostra Carta fondamentale. Nicola non l’ha fatta troppo lunga, ma ci ha proposto una lettura ad alta voce: un brano preso dalla trascrizione di una conversazione di Dossetti nel 1994 con il clero della Diocesi di Concordia- Pordenone. Dossetti non scriveva molto e una volta lasciata la politica non diede mai o quasi mai interviste, perciò esistono pochi testi sull’evoluzione del suo pensiero e del suo impegno. Uno di questi e appunto ciò che disse a un gruppo ristretto di preti, presente il vescovo Sennen Corra, alla Casa Madonna Pellegrina di Pordenone. Dossetti raccontò di sè, della sua famiglia, della guerra e della Resistenza, del suo breve e a suo dire casuale passaggio in politica, della scelta monastica e dell’attualità. Ecco il passaggio scelto e letto a tutti da Nicola.
«Nel ‘15 avevo due anni, e ricordo lo scoppio della guerra; ricordo benissimo certi episodi della medesima, e ho vivo nella mente il ricordo della sera di Caporetto: avevo quattro anni. Sono andato al ginnasio nei giorni della Marcia su Roma, nei giorni dell’avvento del fascismo. Ripensando poi con intelligenza matura quell’evento, ho confermato le prime impressioni infantili o da adolescente del medesimo, cioè l’impressione – per dirla globalmente – di una grande farsa: una grande farsa accompagnata da una grande diseducazione del nostro Paese e del nostro popolo, assieme all’impressione di un grande inganno, anche se seguito certamente con illusione da una maggioranza, che pero sempre più si lasciava ingannare e fuorviare. Quindi c’è una prima cosa ben ferma nella maturazione sopravvenuta della mia coscienza e nella riflessione su quegli eventi che la mia fanciullezza, quasi la mia prima adolescenza, aveva vissuto, una riflessione radicale nel profondo: un irriducibile antifascismo, non solo per il passato, ma anche per il presente e per il futuro e per tutto quello che può assimilarsi e preparare un nuovo fascismo. So benissimo che la storia – lo dicevo poco fa – non si ripete mai nella medesima maniera, però si possono dare circostanze simili o similari, che poi finiscono per avere esiti comparabili o per lo meno in qualche modo accostabili. E questo mi sembra il momento di dire che c’è un’incubazione fascista. Non dico che il futuro si presenterà negli stessi termini, ma dico che chi ha vissuto – ancora molto giovane – quella prima esperienza di questa grande farsa e di questa grande teatralità, trova oggi in certi settori della nostra società equivalenze impressionanti. E quindi alla mia coscienza nasce spontanea la medesima reazione. Prima grande cosa che mi pare potervi attestare».
Un’incubazione fascista in corso: è «la prima grande cosa» che fratello Giuseppe «attesta» a un gruppo di preti e al loro vescovo il 17 marzo 1994. La lettura impressiona: per la nettezza dei giudizi e perche Dossetti con grande lucidità indica pericoli che a noi sembrano incombenti proprio oggi – non si fa che parlare di nuovo fascismo e ritorno del fascismo, suscitando a dire il vero l’insofferenza degli storici di mestiere – mentre lui parlava un quarto di secolo fa. Il 17 marzo del ‘94 la destra al potere ancora non c’era ma ci stava arrivando: avrebbe vinto di lì a poco le elezioni, appena dieci giorni dopo la conversazione di Dossetti a Pordenone. Il monaco ed ex politico non aveva capacità divinatorie ma vedeva tracce di «incubazione fascista» in quella fase storica di tumultuoso cambiamento. Era l’epoca del dopo Tangentopoli, con lo sgretolamento delle forze politiche tradizionali, e del cosiddetto sdoganamento della destra neofascista o post fascista del Movimento sociale italiano, trasformato in Alleanza nazionale; erano gli anni della prima affermazione elettorale della Lega Lombarda e della Liga Veneta, attestate su un programma antimeridionalista e secessionista. Tanto bastava a Dossetti per lanciare un forte allarme di fronte a un pubblico davvero singolare: il clero di una piccola diocesi del Nord Italia.