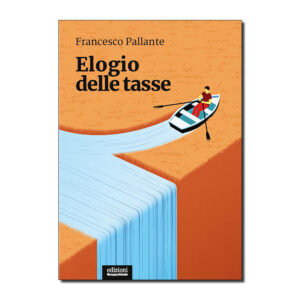Un film del 2019, Il buco, vale meglio di mille libri a illustrare l’orrore che oramai consideriamo normalità.
La vicenda si svolge in una prigione che affonda per centinaia di piani nel sottosuolo. Ogni giorno l’amministrazione penitenziaria prepara una tavola ricca di bevande e cibi prelibati, in quantità più che sufficiente a sfamare tutti i detenuti. Una volta imbandita, la tavola viene fatta scendere lentamente, di piano in piano, attraverso un buco posto al centro della prigione, in modo che i detenuti – ogni piano costituisce una cella – possano nutrirsi. Essere rinchiusi a un piano alto è chiaramente molto vantaggioso, dal momento che si può scegliere cosa mangiare e in quale quantità; man mano che si scende verso il basso, ci si dovrà accontentare di quel che resta. Ciò che usualmente accade è che ai piani alti si abusi della propria posizione di vantaggio, nutrendosi oltre il necessario e schernendo i reclusi dei piani inferiori tramite l’ostentato spreco del cibo. Poche decine di piani più sotto già si è ridotti a succhiare le ossa spolpate ai livelli superiori; ancora più in fondo la sola prospettiva realistica è la morte.
Come se non bastasse, nessuna ragione governa l’assegnazione dei detenuti ai piani: ogni mese avviene una ridefinizione casuale delle collocazioni, sicché stare in alto o in basso non è conseguenza della gravità del crimine commesso, della pena da scontare, della condotta tenuta in prigione o di qualsivoglia altro criterio. Come la lotteria naturale attribuisce a ciascun neonato, alla cieca, una determinata condizione sociale anziché un’altra, allo stesso modo l’assegnazione a un piano o a un altro della prigione è frutto di un meccanismo oscuro e incontrollabile. In questo scenario – una metafora davvero potente di quel che, oggi, è diventato il nostro mondo – il protagonista prova, a rischio della vita, a convincere i detenuti a collaborare tra loro.
La realtà supera la sceneggiatura
Se uno sceneggiatore ha potuto immaginare una storia tanto terribile, è perché, in effetti, la crescita, di anno in anno, della diseguaglianza è un fenomeno oramai ben studiato e conosciuto. L’economista francese Thomas Piketty è colui che forse più efficacemente ha saputo coniugare analisi scientifica e divulgazione, dando alle stampe un best-seller planetario – Il capitale nel XXI secolo (2013) – in cui dimostra con grande ricchezza di dati che, dopo essere parzialmente diminuita tra la fine della seconda guerra mondiale e la metà degli anni Settanta del Novecento, la distanza tra ricchi e poveri ha ricominciato a crescere a un ritmo vertiginoso e appare oggi, rimanendo immutate le cose, inarrestabile.
3 miliardari “valgono” 6 milioni di persone
Secondo Oxfam Italia, che riporta dati del 2019, il 69,8% della ricchezza nazionale italiana è concentrata nelle mani del 20% più ricco della popolazione, mentre il 20% più povero deve accontentarsi dell’1,3% della torta. Una polarizzazione spaventosa, che si inasprisce ulteriormente muovendo verso il vertice della piramide. E così, se il 5% dei più benestanti possiede il 41% della ricchezza complessiva, per l’1% la fetta corrisponde al 22% del totale; se poi ci si spinge sino a considerare soltanto i primi tre italiani che compaiono nella lista dei miliardari stilata dalla rivista Forbes (Giovanni Ferrero, Leonardo Del Vecchio e Massimiliana Landini Aleotti), si scopre che, con 78,5 miliardi complessivi, essi possono fare affidamento su una ricchezza superiore a quella del 10% più povero dei nostri connazionali (circa sei milioni di persone).
La ricchezza si concentra
È l’esito di un andamento risalente nel tempo. Se ne trova conferma nei numeri forniti, nelle sue periodiche informative, da Assogestioni – l’associazione che riunisce gli operatori del private banking –, da cui si ricava che, a partire dalla crisi dei mutui subprime, l’ammontare delle risorse affidate dagli italiani a fondi d’investimento e gestioni di portafogli è sempre aumentato, sino a toccare la cifra record di 2.239 miliardi di euro nel 2020, a fronte degli 841,4 miliardi del 2008.
La banca Credit Suisse aggiunge che i milionari in Italia sono più che triplicati negli ultimi dieci anni, passando da 424.000 nel 2010 a 1.496.000 nel 2019. Un’altra banca svizzera, Ubs, si concentra sui miliardari, censendone quaranta nel 2020. La ricchezza privata è tale che, nonostante un ristagno economico ultradecennale, l’Italia risulta all’ottavo posto nel mondo per ricchezza nazionale: un tesoro pari a 11.360 miliardi di dollari, corrispondenti al 3,15% della ricchezza mondiale (a fronte di una popolazione che supera di poco lo 0,7% del totale planetario).
L’altro lato della medaglia
Sul lato opposto della medaglia sta il deplorevole stato di attuazione dei diritti costituzionali.
Il lavoro – fondamento della Repubblica! – è così carente da far registrare il più basso tasso d’occupazione d’Europa, dopo la Grecia, e quel poco che c’è è così scarsamente tutelato e retribuito da non consentire più, com’era un tempo, l’uscita dalla povertà (addirittura, l’Italia è l’unico Paese in Europa in cui i salari sono diminuiti rispetto al livello medio di trent’anni fa: al punto che, d’inverno, un lavoratore su quattro non può permettersi di riscaldare adeguatamente la propria abitazione). I tassi di inoccupazione femminile e giovanile sono alle stelle, il part-time involontario colpisce 2,7 milioni di persone, il 15% degli occupati è precario (condizione che colpisce il 90% dei nuovi assunti), i morti sul lavoro sono tornati al livello degli anni Cinquanta.
Povertà assoluta
Non stupisce che, secondo l’Istat, la povertà assoluta sia più che raddoppiata negli ultimi dieci anni, arrivando a colpire oltre l’8% della popolazione: circa cinque milioni di individui. La povertà relativa investe più del 15% dei residenti, pari ad altri nove milioni di persone. I minori sono particolarmente colpiti, al punto che – sostiene Save the Children – un bambino su venti non riceve un pasto proteico al giorno. Sulla base di calcoli differenti, l’ufficio statistico dell’Unione europea, Eurostat, attribuisce all’Italia 10,4 milioni di poveri, il maggior numero d’Europa in termini assoluti; rapportato alla popolazione, il dato ci colloca alle spalle soltanto della Romania e della Grecia.
La salute è roba da ricchi
La tutela della salute patisce anch’essa limiti gravissimi, resi drammaticamente evidenti dalla pandemia da Covid-19: un numero inadeguato di posti letto, medici e infermieri, strutture ospedaliere vetuste, carenza di assistenza territoriale, lunghe liste d’attesa, spesa privata in costante aumento (sino, oramai, al 30%o del totale), differenziazioni territoriali tali da costringere i pazienti alla mobilità interregionale. All’origine, una spesa sanitaria del tutto inadeguata, inferiore agli altri Paesi europei a noi paragonabili per dimensione demografica e al di sotto della media Ocse in rapporto sia alla popolazione, sia al Pil.
Casa e assistenza sociale
Ancora peggio per il diritto alla casa, settore in cui gli interventi sono ridotti praticamente a zero. Avere un’abitazione, di fatto, non è più considerato un diritto costituzionale: seicentomila famiglie attendono l’assegnazione di una casa popolare in liste d’attesa infinite, un milione e settecentomila versano in condizioni di disagio abitativo, gli sfratti sono in vertiginoso aumento, così come gli sgomberi compiuti dalla forza pubblica, mentre i fondi sociali per la casa sono sottoalimentati. Il tutto, a fronte di una pletora di alloggi vuoti e inutilizzati, che si calcola ammonti all’incirca a quattro milioni di unità.
L’assistenza sociale è a sua volta in forte regressione. Dedichiamo alla protezione sociale meno risorse pro-capite di Francia e Germania; i fondi sociali sono stati, in anni recenti, letteralmente svuotati; gli enti locali, su cui grava una parte rilevante degli interventi sociali, hanno subito tagli certificati dalla Corte dei Conti in oltre quaranta miliardi di euro. Soprattutto, i servizi sociali incardinati sul territorio sono da anni finanziati sulla base della spesa storica, un criterio incostituzionale che congela le diseguaglianze in modo inaccettabile, continuando a dare a chi già riceveva e a non dare a chi non riceveva. Il Nord drena quasi il 60% della spesa sociale, il Centro e il Sud – dove pure si concentrano i più poveri – si dividono quello che rimane. Come si può ancora parlare di uguaglianza, mantenendo un minimo di credibilità?
Scuola, università, istruzione, giovani
Infine, l’istruzione, la nota forse più dolente. Alla scuola dedichiamo così poche risorse, rispetto al Pil, da risultare quint’ultimi in Europa; per l’università investiamo appena la metà della media Ocse. Eroghiamo un numero irrisorio di borse di studio – un decimo di quel che sarebbe necessario – e, nel contempo, abbiamo le tasse universitarie più elevate (seconde solo a quelle olandesi). Non c’è da stupirsi che le iscrizioni ai nostri atenei stiano tornando solo adesso verso i livelli precedenti la Grande Crisi del 2008 e che la percentuale di popolazione laureata resti ben al di sotto della media europea. Quanto all’istruzione scolastica, impressionano i dati sull’analfabetismo funzionale: un quindicenne su quattro non raggiunge il livello minimo di istruzione matematica e uno su cinque ha gravi lacune nella comprensione di un testo scritto. Spaventosi il tasso di abbandono scolastico (quasi il 15%, contro una media europea dell’11%) e il connesso numero di Neet (Not in Education, Employment or Training), i giovani tra i quindici e i ventinove anni che non studiano, non si formano, non lavorano: addirittura uno su quattro, contro una media europea di poco superiore al 13%.
Il problema non è il reddito di cittadinanza
Siamo, in definitiva, al cospetto di un fallimento epocale, di fronte al quale lasciano sgomenti le posizioni di chi – affermando che la gente deve imparare a soffrire (Renzi), anziché ricorrere al metadone di Stato (Meloni) – si scaglia contro quella pur minima e inadeguata misura che è il reddito di cittadinanza: una vera e propria àncora di salvezza per milioni di persone che in questi mesi sarebbero, altrimenti, andate a fondo. Certo, qualcuno ne ha approfittato, suscitando diffusa indignazione: ma, come mai altrettanta indignazione non è manifestata per l’enorme evasione fiscale – oltre 100 miliardi di euro all’anno – che impedisce la piena attuazione dei diritti costituzionali?