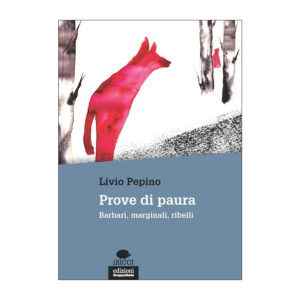Dopo oltre un anno di silenzio complice delle istituzioni, della politica e dell’informazione la mattanza del 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Mara Capua Vetere è infine venuta alla luce. In modo dirompente, con immagini, filmati, grida, pianti, parole («Abbattiamoli come vitelli!») che hanno riempito giornali e televisioni e che non lasciano margini di dubbio su quel che è accaduto quel giorno in carcere.
Il silenzio delle istituzioni
Una mattanza, appunto, di proporzioni abnormi che ha avuto come vittime tutti i detenuti del reparto Nilo della casa circondariale. Una spedizione punitiva che ha visto come protagonisti oltre duecento agenti di polizia penitenziaria venuti anche da altre strutture (sono, ad oggi, ben 52 le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari e oltre 117 gli operatori penitenziari indagati). Un’attività pianificata e organizzata nei particolari in reazione a una protesta avvenuta il giorno prima contro il rischio di diffusione di Covid nell’istituto.
Un fatto deliberatamente nascosto dalle varie articolazioni dell’amministrazione penitenziaria anche avvalendosi del silenzio del personale medico e di false prove costruite a tavolino su presunti reati commessi dai detenuti (a giustificazione di un intervento repressivo energico «teso a ripristinare l’ordine violato»). Una vergogna taciuta per mesi dalle autorità e da gran parte della stampa benché i pestaggi fossero stati denunciati dal garante dei diritti dei detenuti della Campania già due giorni dopo e il procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere fosse noto già nel giugno 2020.
Oggi tutti o quasi (con l’ovvia eccezione di gran parte della destra politica e dei suoi supporter nei media) si stracciano le vesti e fanno a gara nel trovare le parole più aspre per esprimere condanna ed esecrazione. Ma si tratta, per lo più, di parole di circostanza, destinate a rientrare in fretta e disinteressate a indagare le ragioni per cui tutto questo è accaduto e, soprattutto, a rimuoverne le cause.
Banalità del male
Occorre, invece, non fermarsi alla superficie. Se si approfondisce, infatti, emerge subito un apparente paradosso. Le violenze e le sevizie, che integrano anche nel nostro Paese il delitto di tortura (legge 14 luglio 2017, n. 110), evocano situazioni e comportamenti che sembrano estranei a ogni “persona normale”. Nessuno di noi – si dice con orrore – sarebbe mai capace di colpire a freddo con calci o pugni altre persone, di sodomizzarle, insultarle, umiliarle. E tutti proviamo un senso di nausea insopportabile nel vedere le immagini diffuse in questi giorni dalle televisioni o quelle dei giovani (e meno giovani) sopravvissuti alla “macelleria messicana” della Diaz nel caldo luglio del 2001 o, ancora, il volto martoriato di Stefano Cucchi.
Ma poi, se esaminiamo gli identikit dei torturatori, troviamo spesso irreprensibili padri o madri di famiglia pieni di attenzioni nei confronti dei propri figli, vicini della porta accanto «che non farebbero male a una mosca», funzionari pubblici di provata affidabilità. Torna – inevitabilmente – il riferimento alla banalità del male evocata da Hannah Arendt. Si tratta, però, di una categoria che descrive (con grande efficacia) una situazione, non della spiegazione del suo perché.
Una spiegazione può, forse, trovarsi nelle pieghe delle discipline mediche o psichiatriche. Ma anche se così fosse per alcuni o per molti dei torturatori che attraversano il mondo non sarebbe spiegazione sufficiente. Se non altro per il numero di attori – protagonisti, comprimari, esecutori, comparse… ‒ che punteggia il vergognoso scenario della tortura. C’è inevitabilmente dell’altro. Anche perché la tortura ha attraversato i secoli giustificata da filosofi, uomini di stato, giudici, teologi e via elencando. Ha sostenuto regni e dominazioni, salvaguardato religioni, dato soluzione a casi giudiziari, rassicurato singoli e gruppi. E chi l’ha praticata, lungi dal provare vergogna, si è considerato spesso una sorta di salvatore della patria. Non illudiamoci. È ancora così. E continuerà ad esserlo se non se ne estirpano le cause.
Non sono mele marce
Fatti come quelli di Santa Maria Capua Vetere non sono isolati e non riguardano alcune “mele marce” come si usa dire troppo spesso in questi casi. Non si tratta di criminalizzare gratuitamente, con generalizzazioni improprie, delle categorie di operatori dello Stato, ma di trarre le necessarie conseguenze dal numero delle persone coinvolte e dalla frequenza di vicende analoghe.
Un rapporto di Antigone dei giorni scorsi segnala che negli ultimi tre anni sono stati aperti, nel nostro Paese, procedimenti per torture con riferimento a fatti avvenuti, oltre che a Santa Maria Capua Vetere, negli istituti di Ferrara, San Gimignano, Firenze Solliciano, Torino, Palermo, Milano Opera, Melfi, con numerose misure cautelari, alcune condanne già intervenute a seguito di rito abbreviato, coinvolgimento di medici (per mancata refertazione delle lesioni riportate da detenuti), funzionari e di un direttore (per favoreggiamento personale e omissione di denuncia). Senza dimenticare la mattanza, assai simile a quella in esame, che il 3 aprile del 2000 ha aperto il nuovo millennio nel carcere San Sebastiano di Sassari.
I numeri non lasciano dubbi: non sono fatti isolati, riportabili a patologie individuali ma comportamenti che fanno parte di un sistema di governo del carcere. Di più, sono fatti noti, tollerati e coperti dall’istituzione e anche dalla politica, come risulta, nel caso specifico, dal fatto che ancora il 5 novembre 2020 (7 mesi dopo i fatti e quando erano ampiamente note denunce e pendenza di indagini) il Guardasigilli, attraverso una risposta scritta fornita in Commissione giustizia della Camera affidata al sottosegretario Giorgis, affermava che quella svolta a Santa Maria Capua Vetere era stata «una perquisizione straordinaria per una doverosa azione di ripristino della legalità».
Non so se sia esatta l’affermazione secondo cui nulla si muove nell’arcipelago del carcere senza l’assenso o la tolleranza di dirigenti del DAP e ministri, ma certo la prassi della successiva copertura, lungi dal disincentivarli, incoraggia i comportamenti devianti.
Crea il nemico, torturalo, uccidilo
Non basta. C’è anche qualcosa di più generale che ispira o, quantomeno, consente, rende tollerabile la tortura. È una cultura, una visione del mondo, un approccio agli altri e alla realtà più diffuso di quanto si creda, anche se non sempre e necessariamente produttivo di effetti così traumatici. Il suo nucleo forte è che la dignità e la libertà delle persone non sono valori assoluti e intangibili, che fanno capo a tutti e a ciascuno, ma semplici condizioni di fatto rimovibili, soccombenti a fronte di altri valori (veri o presunti) e, soprattutto, non riconosciute al nemico. In sintesi, la prima matrice della tortura – come di altri comportamenti affini (dal genocidio alla pena di morte) – sta nella costruzione di categorie, più o meno ampie, di nemici della società, considerati alla stregua di non persone e, dunque, potenzialmente destinatari di trattamenti diversi (e deteriori) rispetto a quelli riservati ai nostri simili.
Nella storia i processi di costruzione del nemico sono ricorrenti e hanno sempre avuto come componente l’inferiorizzazione delle persone, dei gruppi, dei popoli destinati poi a subire aggressioni, annientamento, trattamenti inumani e degradanti. Se i nemici ‒ i migranti, i marginali, i ribelli, i detenuti e via seguitando potenzialmente all’infinito ‒ sono ontologicamente diversi da noi, se appartengono a un altro universo, il gioco è fatto e la sopraffazione, la prevaricazione, la tortura diventano lecite o addirittura necessarie. Il vero punto sta qui, nel mancato riconoscimento della pari dignità e della uguaglianza delle persone che costituisce il bagaglio identitario, il marchio di fabbrica, di molte forze politiche e culturali, anche oltre le aspettative.
È bene ripeterlo. Inutile illudersi: se non si aggrediscono queste prassi, queste coperture e questa cultura, anche la tortura, pur esecrata a parole, resterà protagonista della scena. Con le conseguenze devastanti, specifiche e generali, che le sono proprie.